Emergenza Coronavirus: il calcio italiano paga gli errori del passato
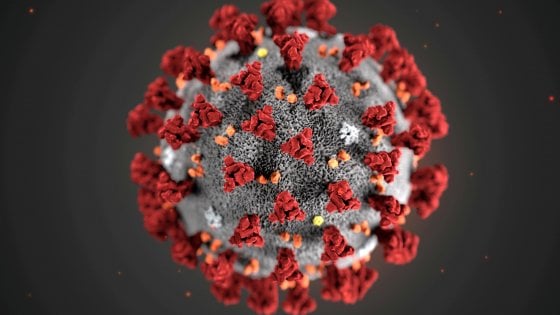
L’emergenza Coronavirus ha costretto la Lega calcio a navigare a vista, portando sul tavolo di crisi più di un’ipotesi di austerity. Il contagio epidemico sta rallentando, ma ancora non si ferma come previsto inizialmente dagli scienziati. Da qui l’accordo sul taglio degli stipendi dei calciatori, deciso ieri in assemblea. In sintesi, 1/6 (oltre il 15%) in caso di chiusura regolare della stagione e 30% se lo “stop” venisse confermato fino al termine.
Il calcio della massima serie paga, in questa fase, gli errori epocali di una classe dirigente, che ha sempre preferito spendere allegramente piuttosto che reinvestire o risparmiare in vista di tempi difficili.
E’ sufficiente prendere in esame la “ripartizione dei costi e ricavi” della Serie A, nel periodo compreso tra il 2013-14 e il 2017-18 (illustrato all’interno del “Report Calcio” di Federcalcio-Arel), per comprendere come il costo del lavoro, ad esempio, non sia mai sceso sotto la soglia del 49% (come nel ’13-’14), raggiungendo il picco del 53% nel ’15-’16, e attestandosi su una media del 50% nell’ultima stagione (’17-’18) oggetto del monitoraggio.
Più della metà dei ricavi vengono assorbiti da questo indicatore, senza poi considerare gli “ammortamenti e le svalutazioni” (compresi tra il 20% e il 24%), Si raggiunge così un livello di pressione non inferiore al 74% (dato stagione 2017-18). Attualmente il rapporto “costo del lavoro per tesserato/ricavi club” è ormai vicino al 55%.
Nel campionato in corso si stima un monte-ingaggi (lordo) pari a 1,33 miliardi di euro. Una cifra troppo elevata per una Serie A, che supera di poco i 3 miliardidi giro d’affari (sempre secondo l’analisi Figc-Arel).
L’attenzione degli analisti si sta focalizzando, soprattutto, sul livello dei salari dei primi sei club (per blasone e bacini di utenza). La Juventus, quest’anno, prima dell’accordo sul taglio degli stipendi, avrebbe pagato 274 milioni di euro; l’AS Roma 180 milioni; l’Inter 132 milioni; il Napoli 110 milioni; il Milan (fuori dalle Coppe europee quest’anno) 102,2 milioni, mentre la Lazio, provvisoriamente seconda in classifica (ad appena un punto dai campioni d’Italia in carica) spenderà 80 milioni di euro (circa 1/3 dell’intero monte ingaggi bianconero).
La decisione della Lega calcio, contestata da Damiano Tommasi (presidente AIC), è il risultato di un’errata visione globale da parte della stragrande maggioranza dei presidenti.
Negli ultimi 10 anni sono stati inaugurati o ristrutturati integralmente appena 4 impianti (l’Allianz stadium di Torino, il “Benito Stirpe “di Frosinone, la Dacia Arena di Udine e il Mapei stadium di Reggio Emilia). Atalanta e Cagliari calcio sono al lavoro per seguire questi modelli vincenti, ma la capacità progettuale del sistema calcio tricolore è bassissima.
Le società si sono appiattite sui diritti tv (oggi “audiovisivi”). Pesano mediamente per il 40%, mentre i ricavi da stadio (il tradizionale “botteghino”) non superano la percentuale del 10%. Se si considera il periodo 2013-14/2017-18 si è passati appena dall’8% al 10%.
Praticamente, solo considerando questa finestra temporale, si sono persi cinque anni e anche l’inaugurazione dello Juventus stadium (8 settembre 2011), oggi sponsorizzato dal gruppo Allianz, non è stato quell’acceleratore di sistema che tutti si aspettavano.
La ragione di questo errore è legata a diversi fattori: i presidenti, ad esempio, non investono direttamente sui progetti societari. Non c’è più capitale di rischio, ma solo di “debito” e per tutti (stretti dai paletti del fair play finanziario), il modello di riferimento è l’autogestionefinanziaria. Ovvero spendo solo quanto incasso.Troppo poco per sognare, ma anche per difendersi in fasi contingenti come l’attuale.
Si lavora con le entrate tipiche dei calcio (chiedendo alle banche di riferimento anticipi sui contratti di Sky e Dazn), senza immettere denaro fresco, senza aprirsi a nuovi investitori, senza coinvolgere direttamente gli sponsor (solo Juventus e Lazio, negli anni passati, hanno sperimentato questa strada per poi abbandonarla) e senza, soprattutto, investire in progetti di impiantistica sportiva che farebbero volare i ricavi (non meno del 20-30% nei primi anni di attività). Logico quindi chiedere ai calciatori, principale “voce di costo”, un sacrificio, o al betting di “cedere” l’1% della raccolta del mercato italiano (circa 200 milioni di euro), per provare a resistere allo tsunami Covid-19, ma, ancora una volta, non vediamo progettualità di lungo termine ma solo soluzioni tampone

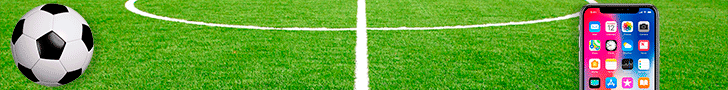



No Comment