Rugby – I numeri del rugby e la sponsorship di Max
Ottantamila tesserati. Ventisette milioni di bilancio. Una Nazionale sempre più forte (tra le prime 10 al mondo), una base sempre più allargata, un movimento sempre più credibile. Da almeno 10 anni il rugby italiano non smette di crescere. E i programmi sono ambiziosi: 100 mila tesserati e 30 milioni di bilancio, tanto per cominciare, una Nazionale tra le prime otto, tanto per continuare, e l’organizzazione della Coppa del mondo 2015, altrimenti 2019, e non tanto per finire. Perché non finisce qui: c’è anche un sostegno culturale e commerciale,
di immagine e di prestigio, che alla lunga sta facendo scuola, tendenza, forse
un giorno anche storia.
Se una volta erano quelli che si picchiavano mentre scorrevano, rapidissimi, i titoli di coda della Domenica sportiva; se poi erano quelli delle tante, troppe sconfitte onorevoli, sempre a un passo dalla svolta, dal giro di boa, dal Paradiso; se infine sono quelli arrivati nudi, prima che in meta, sulle pagine delle pubblicità e sulle copertine delle riviste, con certi fisici scolpiti in palestra e collaudati a forza di scontri in tutti e due gli emisferi; finalmente oggi non sono più soltanto rugbisti, ma uomini di rugby. Potrà anche sembrare paradossale: ma fuori dalle Olimpiadi ci sono ormai soltanto loro, gli uomini di rugby, i più legati a certi principi morali e comportamentali. In fondo superiori perfino al riconoscimento olimpico ufficiale: basta, e avanza, quel senso di appartenenza a uno sport, alla sua disciplina e al suo codice. D’onore.
Come sono lontani i tempi in cui Oscar Wilde considerava il pallone ovale “una buona occasione per tenere 30 energumeni lontano dal centro della città”, anche perché ormai gli stadi sono nel centro delle città. E com’è sempre attuale il motto dei Barbarians, la più celebre squadra a inviti: “Un gioco per gentiluomini di ogni classe”. Tant’è vero che ancora, e sempre più spesso, quando c’è da fare un paragone, si prende, come esempio buono, proprio il rugby: la pacifica invasione delle stazioni e delle città, la festa prima e dopo la partita, perfino la vendita degli alcolici (birra, a dire la verità) fuori e dentro lo stadio, i tifosi mischiati sulle tribune, i bambini portati per un’ora e mezzo di educazione civica e sportiva come in una gita scolastica. Il riconoscimento più importante viene dal calcio, quando ai giocatori è stato imposto “il terzo tempo” del rugby. Che poi, a ben considerarlo, è stato tutto un enorme equivoco: ai calciatori si chiedeva di disporsi a corridoio, per stringere la mano agli avversari; invece il terzo tempo dei rugbisti significa ritrovarsi, dopo la doccia, a chiacchierare anche del match davanti a un piatto di spaghetti e a un boccale di birra. E non è mai stato imposto: c’era, c’è, si faceva, si fa.
Il rugby non è un mondo a parte: anche qui ci sono gli sciocchi e i superficiali, anche qui esistono i furbi e gli approfittatori, anche qui si cercano scorciatoie e si trovano sprechi. Ma certe caratteristiche originali resistono al di là dei tempi. Introdotto ufficialmente nel 1995, il professionismo riguarda pochi protagonisti, ha cambiato solo il vertice, ma il resto è ancorato alla passione, al volontariato, a quello spirito missionario che anima non solo gli uomini (e le donne) di rugby, ma gli uomini (e le donne) di sport. C’è, e ci sarà sempre, gente che si occupa delle maglie dei panini, dei palloni, delle righe sul campo, soprattutto di quelle forme di autofinanziamento (cene, cravatte, annuari, tessere…) che regalano la sopravvivenza. Ed è questa base, ovale e anonima, a garantire e custodire e rinnovare il senso di appartenenza a un popolo riconoscibile, a dei valori condivisi, a delle tradizioni fondanti. Il resto lo fa il gioco nella sua essenza. Per dirne una: forse anche un rugbista protesterebbe, ma rivolgersi all’arbitro non è possibile, e i 10 metri di terreno che si perdono senza neanche poter lottare sono una maledizione, di più: un’umiliazione.
Molto c’è da fare, chiaro. E la crisi della Royal Bank of Scotland, principale sponsor del Sei Nazioni, potrebbe riflettersi a cascata sull’intero movimento, anche italiano. Ma alcune certezze rimangono. Il Benetton, ad esempio. Un caso unico. Trent’anni (nel 2009) con lo stesso sponsor, tanto da creare un caso di sovrapposizione, di identificazione totale: Benetton è Treviso, Treviso è Benetton. Un marchio che copre il prodotto: come per la Nutella, come per lo Scottex. Poi il concetto di polisportiva: non solo rugby, ma anche basket e pallavolo. Poi l’idea di una cittadella dello sport: 26 anni di vita, tre palestre, sei campi da rugby, una pista per la corsa campestre, un percorso-vita, tre campi scoperti di basket e pallavolo e due di beach volley, un club di fitness, una piscina scoperta, un campo da golf, e ancora sale e padiglioni, foresterie e laboratori, biblioteca e centro di riabilitazione. Poi una manifestazione, il Trofeo Topolino di rugby, che due giorni l’anno richiama 4.500 bambini più i genitori. Poi c’è anche una squadra, il Benetton, che non è l’unico sponsor (la nostra maglia, confessò qualche anno fa il mediano di mischia Andy Moore, ha così tanti marchi che sembra di essere in Piccadilly Circus), 400 atleti fra uomini e donne, prima e seconda squadre e giovanili e minirugby, maglie a strisce bianche e verdi, orizzontali, gusto estetico del gioco ma anche più concretezza agonistica e più solidità mentale, e ancora una volta senso di appartenenza, rispetto dei valori. Perché il professionismo del rugby va avanti qualche anno, il professionismo nella vita dura per sempre. Così, quando il seconda linea Antonio Pavanello, fra una touche contro il Munster e una maul contro il Cardiff, lo scorso settembre si è laureato in Architettura, è come se tutto il Benetton fosse andato in meta.
fonte: "MAX"

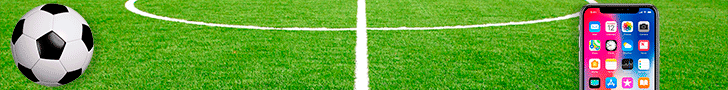

No Comment